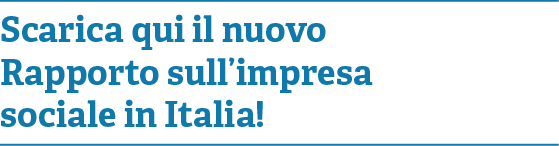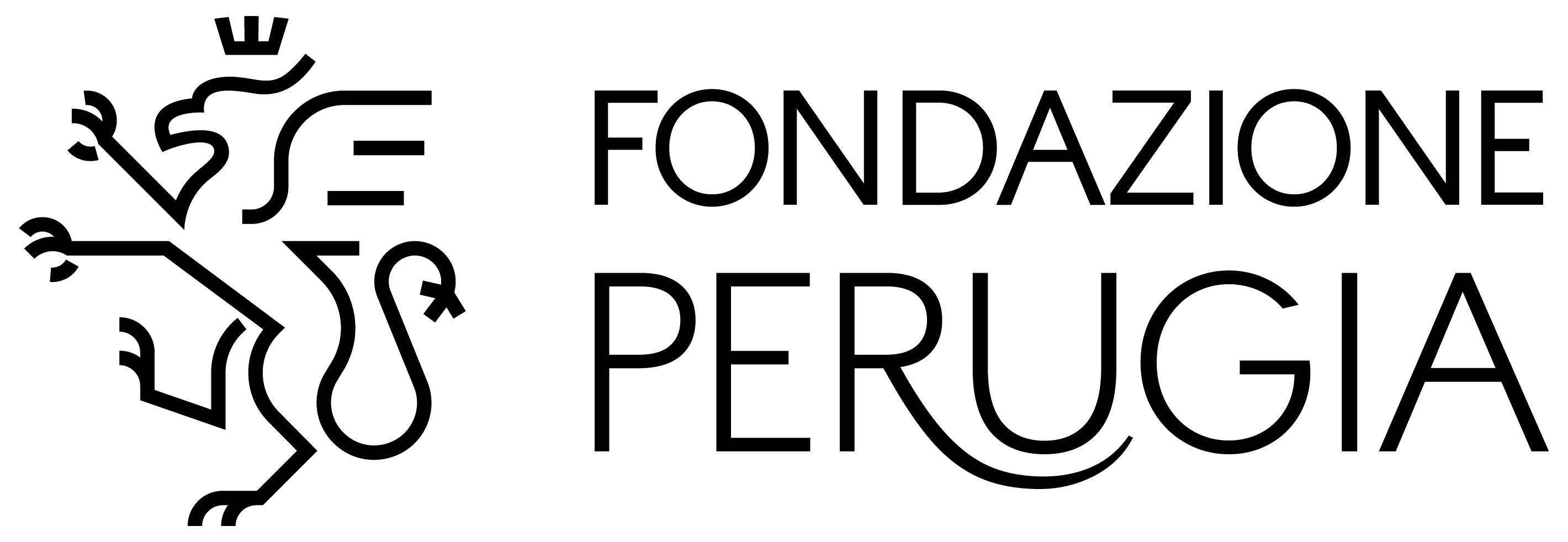Il ruolo delle reti locali tra nuove esigenze di rappresentanza e costruzione di sistemi territoriali d’impresa
Flaviano Zandonai – IRIS Network
Lo sviluppo dell’imprenditoria sociale in Italia ha raggiunto dimensioni considerevoli, almeno da un punto di vista quantitativo (numero di organizzazioni, addetti, volontari, giro d’affari). In nessun altro pese europeo, infatti, questo particolare fenomeno imprenditoriale ha trovato una diffusione così evidente e che, peraltro, si è realizzata in un arco di tempo relativamente contenuto (20-25 anni).
A fronte di questa tendenza alla crescita, nel corso del tempo si sono succeduti, sempre più numerosi, contributi e prese di posizione che avevano l’obiettivo di individuare i fattori in grado di interpretare lo sviluppo di questo fenomeno, andandoli a ricercare sia all’interno di queste imprese, sia nei contesti socio economici in cui esse operano. L’individuazione dei fattori di sviluppo dell’imprenditoria sociale non è naturalmente fine a se stessa, ma rimanda a necessità molto concrete: ad esempio, è possibile comprendere se le condizioni che hanno sostenuto la nascita di queste imprese sono più di natura congiunturale che strutturale, oppure se tali condizioni possono essere generalizzate a livello nazionale o sono invece da modulare in maniera significativa rispetto alle condizioni locali; infine, può essere utile anche cercare di individuare eventuali nuovi fattori che si profilano all’orizzonte, consentendo così di spiegare non solo l’origine e lo stato attuale del fenomeno, ma anche di delineare uno (o più) “scenari futuri” (almeno nel breve periodo).
Fra le varie spiegazioni proposte, una in particolare ha fatto risalire lo sviluppo delle imprese sociali alla loro capacità di “fare rete”, ovvero di definire strategie e di individuare strutture adeguate a creare legami di carattere inter-organizzativo sempre più diffusi, solidi e articolati. Il riferimento alla capacità di networking delle imprese sociali come uno dei possibili fattori in grado di interpretare la loro traiettoria di sviluppo presenta almeno tre aspetti di interesse specifico.
1. In primo luogo, si tratta di un fattore endogeno, riferito cioè alla capacità interna al settore di determinare in forma (relativamente) autonoma il proprio percorso, a fronte di una certa preferenza a privilegiare elementi di sviluppo che invece fanno più riferimento a variabili esogene come le caratteristiche dei sistemi di welfare, l’evoluzione normativa, le trasformazioni dei contesti sociali, ecc. rispetto alle quali l’impresa sociale appare più come una sorta di “derivazione”.
2. In secondo luogo, si tratta di un elemento che è strettamente legato alla forma giuridica della cooperazione sociale, consentendo così di connotare in maniera piuttosto netta questa esperienza anche rispetto ad altre forme organizzative “limitrofe” come i soggetti di terzo settore e dell’economia sociale (altre tipologie cooperative, organizzazioni di volontariato, associazioni, ecc.), dove il fenomeno della creazione di reti appare meno sviluppato, o dove, addirittura, hanno prevalso modelli di sviluppo alternativi (ad esempio fusioni in grandi strutture o, al contrario, permanenza di una presenza “puntiforme” sul territorio).
3. Infine, la diffusione dei sistemi di relazione inter-organizzativa tra imprese sociali è tale da poter ipotizzare che questo fattore abbia raggiunto un “peso specifico” notevole – sia per numero di organizzazioni a rete presenti, sia per le funzioni e i compiti che esse svolgono – non solo per spiegare ma anche per orientare in modo significativo lo sviluppo “dall’interno” di queste imprese, sia a livello locale, ma anche in contesti territoriali più ampi.
A fronte di questi elementi di interesse specifico per questa tematica, dall’osservazione empirica emergono alcuni elementi di mutamento, trasformazione, e, inevitabilmente, crisi che riguardano le reti fra imprese sociali. Le principali tensioni riguardano i seguenti fattori.
* La diffusione delle reti consortili, che presenta accentuati differenziali a livello territoriale, sia per macro area (con una prevalenza delle regioni centro settentrionali a discapito di quelle meridionali) ma anche in contesti micro (da provincia a provincia), ponendo quindi interrogativi rispetto alle variabili che ne determinano lo sviluppo.
* Gli elementi fondanti della mission consortile, dove si compongono, a volte in maniera non chiaramente definita, elementi “di scopo” legati allo svolgimento di attività specifiche (legate, ad esempio, a progettualità comuni) con esigenze di una più generale “rappresentanza” del settore.
* Le funzioni e le attività svolte, rispetto alle quali si nota, accanto ad una crescita sempre più accentuata per quantità e diversificazione, l’emergere sempre più evidente del dilemma legato alla svolgimento “in proprio”, piuttosto che all’esternalizzazione presso altri soggetti con i quali si costruiscono “reti di reti”.
* La composizione della compagine sociale mette in luce una tensione evidente tra modelli di rete di tipo “mutualistico” (che tutelano cioè gli interessi delle organizzazioni aderenti) e modelli che invece si fanno carico delle finalità di interesse generale e di apertura alla comunità tipici dell’impresa sociale, riproponendo anche a livello di rete modelli organizzativi di tipo multi-stakeholder.
* L’assetto di governance rappresenta un ulteriore, cruciale, ambito di osservazione, perché costituisce un importante punto di osservazione del ciclo di vita di una rete di imprese sociali. Si nota infatti un’evoluzione che va da assetti di tipo aggregativi, a strutture da centro servizi, fino a veri e propri imprese-rete territoriali, dove il network assume lo status di soggetto imprenditoriale sui generis, con evidenti ricadute a livello di legami di interdipendenza interni alla rete e di rapporti tra questa e il proprio contesto di riferimento.
* Il rapporto con il territorio, che impone alle reti un costante lavoro di modulazione rispetto a confini che appaiono sempre più mutevoli e sempre meno corrispondenti ad ambiti predefiniti (ad esempio i confini amministrativi), contribuendo così a definire conformazioni territoriali inedite su nuove basi “geo-comunitarie”.
* Il ruolo dei gruppi dirigenti, da cui si intravede, da un lato, un nuovo, potenziale profilo di manager di rete, ma d’altro canto, il permanere di legami di appartenenza multipli presso diverse strutture organizzative.
Da questo excursus sui principali elementi di trasformazione e innovazione delle reti fra imprese sociali si possono proporre alcune considerazioni che, nel loro insieme, cercano di rispondere al seguente quesito: si può ancora contare sulla capacità di far rete dell’imprenditoria sociale per sostenere il suo sviluppo? Se è vero infatti che nella fase di nascita la propensione al networking ha costituito un importante elemento di successo, oggi – e soprattutto per il futuro – non è ancora chiaro quale tipo di ruolo potranno svolgere i soggetti di rete per rispondere alle sfide poste da mutamenti che riguardano sia la struttura interna delle imprese sociali, sia i contesti socio economici in cui essa si trova e si troverà ad operare. In termini generali, la sfida consiste nel coniugare due tendenze divergenti: da un lato l’istituzionalizzazione dell’impresa sociale come fenomeno imprenditoriale che ha superato la fase di start-up, ma d’altro canto è necessario confrontarsi con la crescente eterogeneità delle forme che la stessa imprenditoria sociale può e potrà assumere (per forma giuridica, ambito di attività, organizzazione, governance, ecc.) anche grazie alle recenti innovazioni normative.
In generale, le reti dell’imprenditoria sociale si trovano al centro di un campo di tensioni definito intorno a tre polarità che costituiscono altrettanti possibili significati da attribuire al concetto di “rappresentanza”.
– La prima polarità corrisponde alle classiche forme di rappresentanza basate sul “peso quantitativo” (numero di soggetti aderenti, performance economiche e occupazionali, ecc.) e quindi su un modello di rete che tende all’aggregazione il più ampia possibile, facendo leva su elementi di valore e identità fondati su elementi generali di “scenario”: le matrici culturali / ideologiche, i confini territoriali su base amministrativa, ecc.
– La seconda consiste invece in una reticolarità di tipo strumentale che si basa su un principio di mutualità fra i soci; la rete sviluppa quindi nodi specialistici che agiscono in veste di agenzia di servizi (general contractor, amministrazione, ecc.), senza presupporre significativi elementi di valore, se non l’interesse specifico derivante, ad esempio, da economie di scala o dallo sviluppo del business in settori di interesse comune.
– La terza polarità consiste invece in un modello di networking che si sviluppa intorno a progettualità trasversali alle tradizionali partizioni del welfare (per settore di intervento, tipologia di soggetti beneficiari e attuatori, ecc.) e che si basano sulla composizione degli interessi e degli apporti di attori diversi, (informali e istituzionali, pubblici e privati, su base locale e nazionale). In questo senso le reti delle imprese sociali assumono sempre più spesso la conformazione di “filiere progettuali” che si compongono e ricompongono su basi territoriali inedite e con il contributo attivo di diversi stakeholder.
A fronte di un contesto caratterizzato da forte dinamicità e innovazione assume una posizione centrale il tema delle risorse (economiche e umane) destinate a sostenere l’infrastrutturazione in rete delle imprese sociali. Da questo punto di vista l’orizzonte presenta luci e ombre: da un lato i segnali di crisi nei principali mercati delle imprese sociali (quelli pubblici soprattutto) cominciano a riverberarsi anche nei risultati di esercizio dei consorzi. Ma, d’altro canto, va osservato che si moltiplicano le risorse dedicate allo sviluppo del networking grazie agli interventi promossi da parte di soggetti diversi (si pesi, ad esempio ai progetti Equal del Fse). Si tratta spesso di risorse di non grande entità, ma specificamente dedicate ad iniziative che riconoscono nell’attività di networking una strategia fondamentale per lo sviluppo e il consolidamento dell’imprenditoria sociale.
Bonomi A. (a cura di) (2004), Il passaparola dell’invisibile. Rappresentazione e voce delle imprese sociali, Laterza, Bari.
Carbognin M. (a cura di) (1999), Il campo delle fragole. Reti di imprese e reti di persone nelle imprese sociali italiane, Franco Angeli, Milano.
Centro studi Cgm (a cura di) (2005), Beni comuni. Quarto rapporto sulla cooperazione sociale in Italia, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino.
Scaratti G., Zandonai, F. (2007) (a cura di), I territori dell’invisibile. Culture e pratiche di impresa sociale, Laterza, Bari.
Rullani E. (2006), Rappresentare “chi” o rappresentare “per”? Dalla conta al dialogo, in “Communitas”, n. 8, pp. 253-270.
3